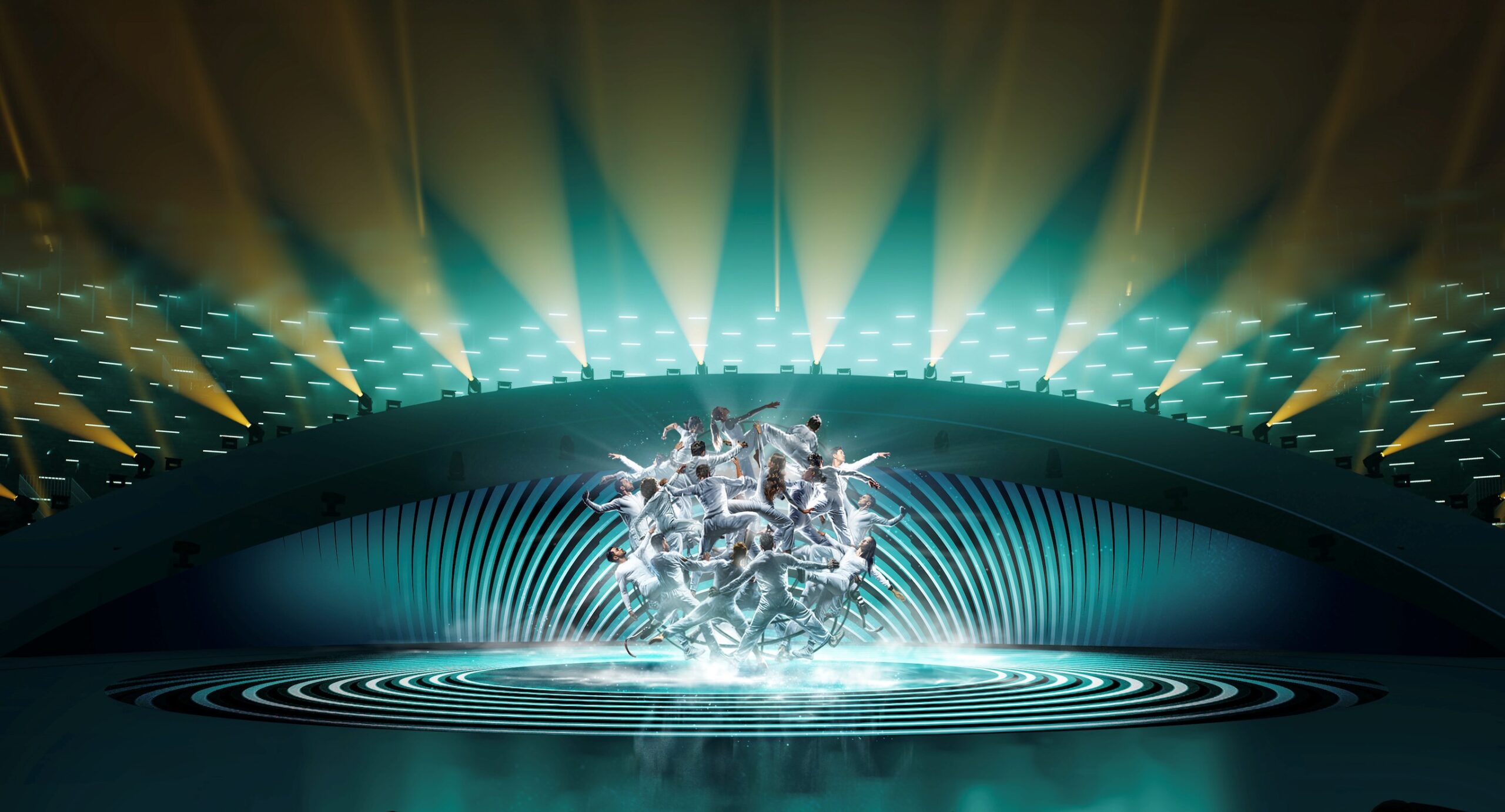di Maurizio Boldrini
Giacomo Todeschini è uno dei più apprezzati docenti di storia economica e del pensiero economico medievale. Da decenni studia e pubblica rilevanti contributi sulle dinamiche attraverso le quali si è formato il mercato economico e finanziario in quel lungo e complesso periodo della storia e sull’incidenza che, in questo processo, ha avuto la religione cristiana. Il suo ultimo libro, “Seconda mano. Il valore delle cose fra medioevo e età moderna” della casa editrice Salerno, è da poco nelle librerie. Su questo volume, come su alcuni dei suoi precedenti studi, ci sono stati e ci sono serrati confronti tra esperti e docenti in tutta Europa. Io mi limito, nel suo buon ritiro di Santa Fiora, sul monte Amiata, in un tempo che tarda prender forma estiva, a porgli qualche domanda.
Nel titolo del tuo ultimo libro, “Seconda mano”, non ti riferisci solo ad oggetti usati e rivenduti. Questi prodotti, staccati dal loro contesto e passati di mano, mutano natura. Di che tipo di oggetti si tratta? Quali sono i meccanismi che determinano questa mutazione? E come avviene il cambiamento della valutazione?
Fra Tre e Quattrocento soprattutto nell’Europa mediterranea, fra Italia, Spagna e Francia, avvenne quella che molti storici hanno definito una rivoluzione dei consumi, ossia una crescita del numero dei consumatori e delle merci in circolazione. Quella che si verificò al passaggio dall’epoca medievale a quella moderna fu in effetti una trasformazione delle logiche stesse della compravendita e dell’utilizzo delle cose utilizzate più o meno comunemente nella vita di tutti i giorni. Fu nell’ambito di questa trasformazione che l’uso delle cose ritenute necessarie per vivere e di quelle considerate superflue divenne il segnale indicatore dell’appartenenza sociale dei consumatori: del fatto che la gente fosse povera o ricca, ignobile o di buona reputazione, credibile o inaffidabile, solvibile o insolvibile, cristiana o “infedele”, eretica o cattolica, di discendenza islamica o ebraica. Più cose in vendita, più segni di appartenenza. L’inizio di un ordine sociale in contraddizione con quello fino ad allora vigente. Vestiti, suppellettili domestiche, oggetti di arredamento, dalla pentola al piatto, dall’armadio al comò, dal lenzuolo al paramento nuziale, ornamenti, gioielli e guarnizioni, attrezzi da lavoro, ma anche i materiali con i quali le cose venivano fabbricate, legno, marmo, pietra, mattoni, lino, lana, seta, tutto cominciò ad essere venduto non più soltanto o prevalentemente da chi lo produceva ma soprattutto da un popolo di rivenditori al minuto, di dettaglianti, bottegai e negozianti, rigattieri e artigiani, in grado di far fronte alla richiesta in costante aumento di beni di consumo che veniva dagli abitanti delle città e delle campagne. La moltiplicazione degli oggetti usati in circolazione moltiplicò le possibilità di presentarsi come appartenenti a ceti e gruppi sociali di cui in realtà non si faceva parte, confuse l’ordine sociale e fece emergere le sue contraddizioni.
A chi appartenevano, in origine, questi oggetti? E perché i proprietari vendevano? E ancora: chi erano gli acquirenti? Attraverso questi passaggi, mostri con sapienza, come questi processi contribuiscano a cambiare profondamente quei processi produttivi ed economici…
Gli oggetti, manufatti, materie prime, dal taglio di carne al vestito, dalle scarpe ai gioielli, avevano origini svariate, provenivano da lasciti svenduti dagli eredi, da ospedali dove erano morti i ricoverati che non avevano fatto testamento, ma anche da grossisti che vendevano ai dettaglianti partite di merci che poi i dettaglianti o i rigattieri avrebbero rivenduto. Molte cose poi venivano dai banchi di prestito su pegno. In ogni caso l’oggetto “usato” spesso era nuovo, ma veniva considerato usato perché era passato di mano in mano molte volte e non se ne conosceva bene l’origine e il modo di produzione. A questo punto la valutazione o la svalutazione delle cose determinava comunque un prezzo molto lontano da quello derivante dal calcolo del valore del lavoro o dei modi di produzione degli oggetti.
Come si stabiliva il mutamento dei prezzi nel passar di mano in mano. Chi decideva a quale prezzo si comprava l’usato e chi fissava il loro valore: il venditore, l’acquirente, il mercato?
Le cose usate che poi, come si è detto a volte erano perfettamente nuove, avevano un valore e un prezzo determinati dalle situazioni di mercato e dal peso sociale delle persone o dei gruppi che componevano i mercati in quanto venditori e acquirenti. Questo significava non tanto, come si usa dire, che il loro prezzo era il risultato di un astratto rapporto fra domanda e offerta, ma piuttosto che il prezzo di un oggetto “usato” o rivenduto al dettaglio dipendeva dall’autorevolezza del venditore e dal peso sociale oltre che dal desiderio del compratore. Gli oggetti impegnati e non riscossi rivenduti da un usuraio, ad esempio, avevano un valore più basso di quelli rivenduti da un’Opera Pia, ma questo valore poteva poi rialzarsi se gli acquirenti li desideravano fortemente e, se appartenevano a classi agiate, potevano permettersi di pagare di più.
Questo passar di mano di oggetti che si trasformavano in denaro quali classi sociali arricchiva? Chi ne traeva profitto? In quale modo questa forma diversa di mercato innesca profondi cambiamenti nel meccanismo economico di questi lunghi secoli.
Il commercio al dettaglio e nel suo ambito quello dell’usato creò fra medioevo ed età moderna un ceto di venditori al dettaglio (a volte anche artigiani che trasformavano e rivendevano) sempre più importante nelle città europee, e in grado di creare un modello professionale per le città non europee che gli europei avrebbero colonizzato. Questo ceto di nuova “borghesia” entrò in tensione con le classi dirigenti più tradizionali, rappresentate dalle aristocrazie locali e dai grandi imprenditori e mercanti-banchieri, che al tempo stesso costituivano le oligarchie al governo. Però, col passare del tempo, soprattutto dal Quattrocento, questa nuova “borghesia” si integrò e divenne parte dei gruppi dirigenti. Si trattò di una vera e propria ascesa e rivoluzione sociale il cui effetto fu di alterare dilatandolo il sistema dei prezzi e dei valori di mercato. In conseguenza di questa trasformazione tutto, dal gioiello allo straccio, poteva essere messo sul mercato, avere un prezzo e venduto al miglior offerente.
Un’ultima domanda: come reagirono a queste nuove di scambio le autorità governative e quelle religiose? In particolare la chiesa cattolica? E si sono più ripetuti, anche modernità e nella contemporaneità, fenomeni analoghi?
Come già accennato le autorità politiche rappresentanti di ceti tradizionalmente al potere e protagoniste di mercati di élite, grandi banchieri, imprenditori e commercianti internazionali (un esempio classico è la famiglia de’ Medici a Firenze), contrastarono questa modificazione delle logiche di mercato. Analogamente gli intellettuali ecclesiastici, nelle Università e dai pulpiti condannarono come inutili e dannosi i traffici dei rivenditori al dettaglio e dei rigattieri (come nel caso di Bernardino da Siena, nel primo Quattrocento). Fino al Cinquecento inoltrato il gioco dei prezzi ossia la loro estrema variabilità prodotta dalla diffusione del commercio al dettaglio e dell’usato, ossia dalla crescente importanza economica di bottegai e rigattieri, veniva interpretato dalle autorità e dagli intellettuali che le rappresentavano e ne divulgavano le idee come una forma di abilità che rendeva questi commercianti simili a maghi e prestigiatori, facendone insomma dei personaggi inquietanti. Il mercato divenne fra Tre e Cinquecento, e poi sempre di più dal Seicento ad oggi, una forma globale della società e della convivenza sociale. Come tale venne spesso avversato e criticato da moralisti, filosofi e teologi, e, a parole, contrastato nelle sue forme più popolari anche dai governanti, che, però, come anche oggi avviene, se ne servivano allo stesso tempo per amministrare i loro territori e per condizionare i consumi dei loro sudditi. La contraddizione fra mercati elitari e mercati quotidiani innescata dal commercio al dettaglio e dell’usato, in altre parole, è stata all’origine delle logiche moderne del mercato che di ogni cosa fanno una merce vendibile. La moltiplicazione all’infinito di merci in vendita, nuove, usate, seminuove o malridotte, benché di continuo deprecata come consumismo forsennato, è ancora oggi funzionale ad equilibri di mercato e politici favoriti e incoraggiati o imposti dalle oligarchie governative, e più in generale da quanti indicano nel mercato la forma ottimale della socialità democratica.